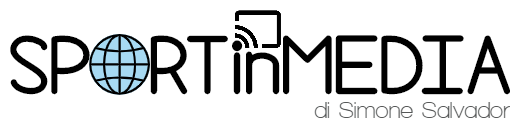Coloro i quali non fanno parte dei 737.000 telespettatori (4% di share) che sabato sera hanno visto su Rai 2 “La bella stagione”, si precipitino su RaiPlay dove il film di Marco Ponti (già regista di “Santa Maradona”, per capirci) è disponibile on demand. Non perdano l’occasione di porsi di fronte ad una bomba emotiva dai mille pregi, completamente scevra da qualsivoglia cedimento tifoso, che per la cura con cui è stata realizzata e per la caratura dei protagonisti rappresenta un unicum nello sterminato panorama dei docufilm sportivi e che è destinato a restare tale per molto e molto tempo.
Certo, il primo fattore si chiama Gianluca Vialli. Vedere “La Bella stagione” nei giorni in cui lui ci ha lasciato è gesto che da solo basterebbe a trasformare la visione nella bomba emotiva di cui sopra. Ma la parte conclusiva del film in cui Gianluca parla con una struggente e limpida sincerità della sua malattia è qualcosa che eleva lui e la sua esperienza ad un livello superiore. Come se sia lui sia la sua carriera ascendessero ad un ruolo umanamente messianico. Si potrebbe perfino dire, senza essere tacciati di eresia, ad un ruolo cristologico: nel senso di come ci si può rapportare alle più tremende fra le esperienze umane come il limite e la sofferenza e farne una testimonianza per tutti. Senza che per questo qualcuno esponga un cartello con su scritto “Santo subito” oppure che qualcun altro ne faccio un santo laico come talvolta ne spuntano nel mondo dell’entertainment.
Ma quel Vialli emerge dopo un’ora e mezza in cui la storia della Samp campione d’Italia prima e quasi campionessa d’Europa poi (obiettivo fallito solo per la scarsa vena realizzativa proprio di Gianluca nella finale di Wembley col Barcellona e per il concomitante killer instinct di Ronald Koeman, capace di scaricare in porta una punizione a pochi minuti dalla fine dei supplementari) ascende a sua volta ad un ruolo simbolico inarrivabile: quello di un gruppo di ragazzi talentuosi che provava piacere nello stare insieme, che pur vivendo nella ricchezza non la ostentava, che si dipingeva sì di biondo platino i capelli ma solo dopo aver vinto lo scudetto a mo’ di celebrazione; e che sarebbe diventato trent’anni dopo il sale del gruppo azzurro capace di vincere l’Europeo nel 2021. Un ruolo sintetizzato dalla presentazione che fa di sé stesso Cerezo a inizio film: “Mi chiamo Toninho Cerezo. E sono felice”.
Due sono gli elementi visuali che rendono il film di Ponti una scommessa riuscita. Il primo è il colore. Forse solo un maestro come Vittorio Storaro sarebbe riuscito a rendere il film blu nella sua interezza. Una colorazione diffusa che attraversa i volti dei narratori, che sottende tutte le sequenze e che arriva negli occhi di chi guarda facendo in modo che i cervelli liberino endorfine. Come un’immagine seppiata porta lo spettatore a calarsi nel passato, in un deja vu o in una memoria, il blu di “La bella stagione” diventa una cifra generazionale. Ponti non ha fatto altro che applicare al suo film sulla Samp il registro (generazionale, appunto) che fece la fortuna di “Santa Maradona”: ma se là il focus era raccontare il disagio degli universitari fuoricorso e dal futuro ammantati di grigio, qui invece quel registro diventa il paradigma, colorato di blu oltremare, dell’essere giovani e spensierati. E nessuno si può sottrarre alla potente evocazione di sentimenti che il film provoca.
E Il fatto che il regista abbia voluto creare proprio questo mondo è confermato anche da un altro fattore: sarà anche per motivi di budget ma le scene di calcio giocato, con i gol di Vialli, Mancini e Lombardo, con le parate di Pagliuca e le randellate di Vierchowod, sono poche e sempre accennate. Diventando funzionali al racconto dei protagonisti, ai loro volti di oggi, ai loro sentimenti e alla celebrazione di un’avventura unica che non può tornare. Come la giovinezza. Così facendo Ponti ha creato un racconto che, raccontando una storia di pallone, dà corpo un pezzo di vita di tutti; e non ad una messa cantata e scontata.
PS. Se qualcuno dei 737.000 spettatori che hanno visto la prima di sabato sera su Rai 2 è riuscito ad arrivare in fondo senza sentire, nel migliore dei casi, un groppo in gola e nel peggiore a dover nascondere il volto per celare le lacrime lo faccia presente. Ma sappia che sarà difficile credergli.
PIERO VALESIO | È stato critico televisivo del quotidiano Tuttosport per oltre vent’anni. Come inviato ha seguito Olimpiadi, grandi eventi di calcio, tennis, Formula 1, Motomondiale e sport invernali. Dal 2016 al 2020 ha diretto il canale televisivo Supertennis e ha curato la comunicazione degli Internazionali d’Italia. Ha tenuto e tiene corsi di giornalismo e di comunicazione sportiva. Nel 2015 ha vinto il Premio Coni per la narrativa inedita con il racconto “Marcialonga Blues”. Ha scritto libri per grandi (“E vissero felici e lontani” con Antonella Piperno, Perrone editore) e piccini (“Cronache di Befa”, Biancoenero edizioni).
Cura per Sport in Media la rubrica “La Nuca di McKinley” e durante i Mondiali di calcio 2022 ha realizzato la video-rubrica “Qatarinfrangenze“.
TUTTE LE PUNTATE DE “LA NUCA DI MC KINLEY”
IN MEDIA(S) RES | IL PODCAST SU SPORT&MEDIA