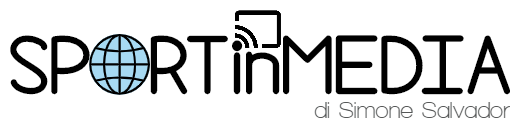In questi giorni natalizi è passata quasi inosservata un’intervista di Angelo Carotenuto (La Repubblica) a Federico Buffa,considerato quasi unanimamente il miglior narratore sportivo (o storyteller secondo la definizione più trendy) italiano. Colui il quale, di fatto, ha proiettato il racconto di storie sportive in un’altra dimensione. Prima di lui, solo Giorgio Porrà (vi ricordate “Lo Sciagurato Egidio”?) e “Sfide” di Rai 3 hanno solcato questa via, considerata secondaria rispetto all’opinionismo istantaneo, quello a uso e consumo di social e tribunali mediatici aperti h24.
FEDERICO BUFFA – IL RACCONTO SPORTIVO E LA MEMORIA CORTA ITALIANA
In questa intervista a Repubblica, Federico Buffa è entrato maggiormente nel personale, toccando alcuni argomenti affascinanti e altri più delicati. In particolare, ci hanno colpito i passaggi su chi siano i suoi modelli, sui retroscena legati al suo addio repentino a Sky Calcio Show e sulla memoria cortissima di tifosi e addetti ai lavori nello sport italiano. Un tema, quest’ultimo, che meriterebbe un approfondimento a latere. Sempre più, infatti, emerge la tendenza a giudicare in modo assolutistico, con toni pressoché definitivi, una singola partita o una prestazione durante una stagione. E non stiamo parlando della gara delle Olimpiadi che vale un’intera carriera. Tifosi e media – al folle ritmo dei social – tendono a emettere sentenze definitive (trionfo/fallimento) in base al risultato di una partita interlocutoria di inizio/metà stagione, salvo poi cambiare diametralmente opinione la settimana successiva. Non ci può sorprendere, quindi, se – come sottolinea giustamente Buffa – all’estero abbattano e ricostruiscano stadi e impianti, mettendo targhe anche per imprese sportive secondarie, mentre in Italia al CT bi-campione del mondo, Vittorio Pozzo, sia dedicato solo uno stadio “minore” come quello di Biella.
FEDERICO BUFFA – STORYTELLING PAROLA OSCENA. DOPO SKY CALCIO SHOW RICEVETTI MESSAGGI ANONIMI E MINACCE
Queste alcune delle risposte più interessanti date da Federico Buffa a La Repubblica (notevole e assolutamente condivisibile l’idiosincrasia per la parola “storytelling”).
Com’è finito a raccontare lo sport? Sono stato salvato dalle acque. Sono un avvocato ma non volevo esercitare. Sapendomi baskettaro, l’allora direttore di Tele+, Andrea Bassani, mi chiamò a commentare delle partite. Vent’anni dopo mi ha confessato che l’AD di allora, alla prima telecronaca disse: non me lo fate sentire mai più.
Che le pare della parola storytelling? Oscena. Tra narratore e storyteller è molto meglio narratore. Non capisco perché tante volte una bella parola italiana sia sopravanzata da un’altra meno bella. Ora pare che tutto sia storytelling ma le storie sono sempre esistite. Casomai esistono stili diversi di narrazione.
Il suo qual è? Quando ho iniziato presi a modello Philippe Daverio in Passepartout. Ho tutte le puntate registrate. Servizio Pubblico puro. (…) Quello che mi piace del giornalismo sportivo italiano è che ci sono delle firme eccezionali, con un timbro diverso. Gianni Clerici dà l’idea di come di possa parlare di sport senza parlare di sport. Una roba per fuoriclasse.
Non le danno mai del passatista? Sono abbastanza abile nell’anticipare l’obiezione. È un privilegio raccontare storie del passato anziché dell’attualità. Ti salva. Non ho nessun problema ad ammettere che questo non è più il mio mondo. Non ho attrazione per i social media. Ho un’ossessione per la privacy. Vivo per conto mio con le persone che mi piacciono. Ammetto di essere un anziano.
Questa sua fuga dall’attualità c’entra con il salotto calcistico abbandonato anni fa dopo una puntata? Quella è una storia bruttissima. I due giorni successivi ero frastornato. Ricevetti messaggi anonimi e telefonate che dicevano “attento a come parli”, calcio uguale voti, sappiamo che lei ha aderito al partito radicale. Era vero. Sono cresciuto con le battaglie per i diritti civili negli anni ’70. Mi chiedevo come fanno a saperlo? Non era la mia taza di tè. Io sono quello che racconta perché Lebron perde le finali.
Con quella domanda in spagnolo a Luis Enrique si presentò come un alieno. Imperdonabile. Io non do molta importanza a quel passaggio. Volevo fargli i complimenti ma fu una pessima esibizione da parte mia. Non dovevo fare la trasmissione e la feci male. Per stare seduto su quello sgabello bisogna avere spalle che non ho e che non voglio avere.
Non resterà che la memoria? In tutto il mondo buttano giù gli stadi e mettono targhe. Noi non sappiamo nemmeno dove si è giocata la finale dei Mondiali del 1934. A Montevideo, davanti a una tintoria, c’è la porta dello stadio dovge un operaio della Peugeot segnò il primo gol in un Mondiale. Lo hanno demolito ma lo ricordano. A Vittorio Pozzo è dedicato solo lo stadio di Biella. Secondo me sbagliamo noi.
Questa l’intervista completa, tratta dal gruppo Facebook Bibliocalcio.